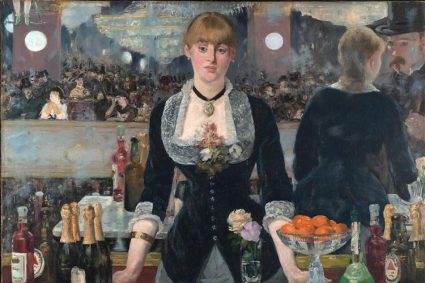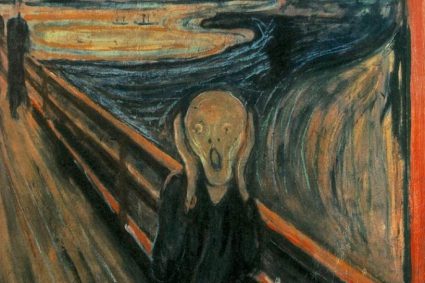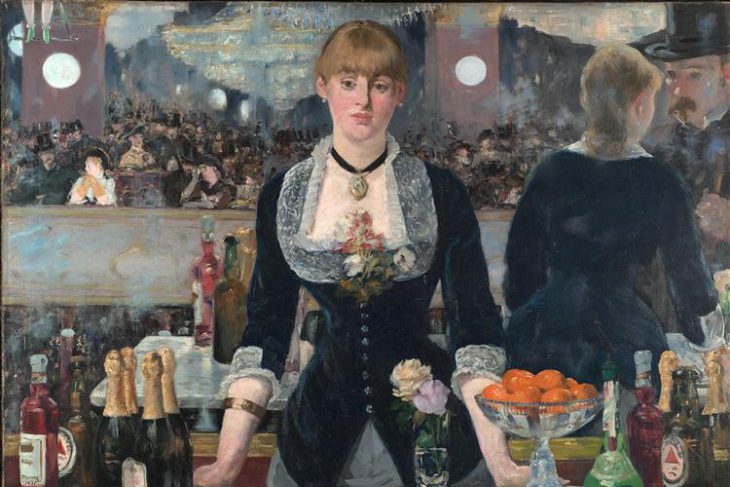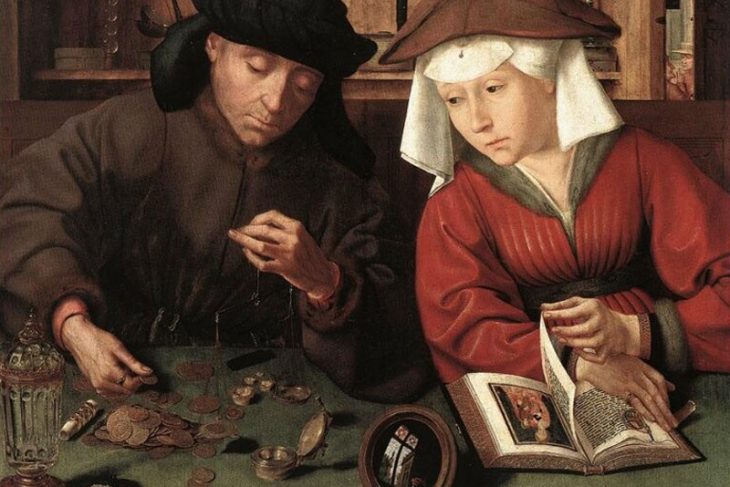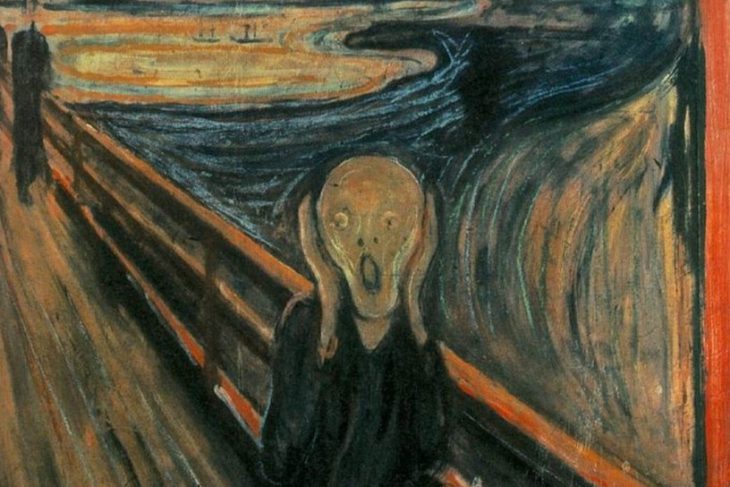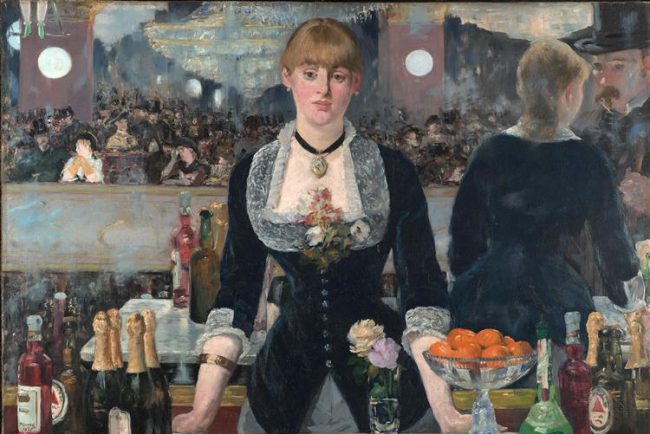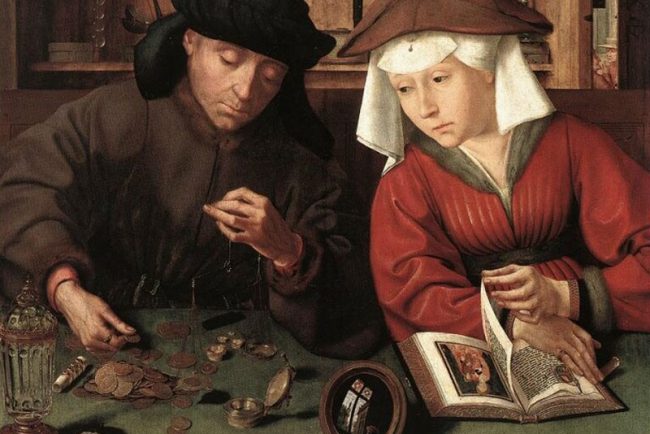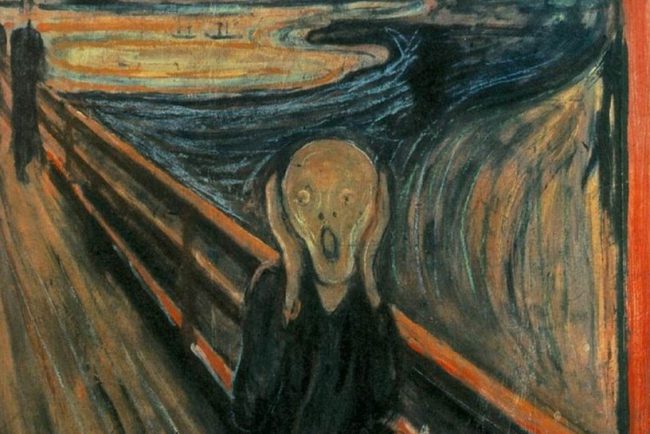Molto spesso nella vita di tutti i giorni , ed in particolare nei social, a fronte di una discussione su di un dato argomento, capita di reagire con dichiarazioni o commenti un po’ sopra le righe, con la conseguenza di far insorgere sia in chi proferisce una data asserzione e sia in chi la riceve, il dubbio se sussista o meno il reato di diffamazione.
Preliminarmente, bisogna ricordare che un reato, in generale, non si configura in presenza di una causa di giustificazione.
In generale, le cause di giustificazione, sono quelle situazioni che non si limitano a escludere la pena, ma che eliminano proprio il reato, rientrano in tale categoria la legittima difesa, lo stato di necessità l’esercizio di un diritto, il consenso dell’avente diritto, l’adempimento di un dovere, l’uso legittimo delle armi.
In presenza di una causa di giustificazione Il fatto è, quindi lecito ab origine.
Con riferimento al reato di diffamazione, una importante causa di giustificazione è data dall’esercizio del “Diritto di critica”, che rientra nella categoria dell’esercizio di un diritto di cui all’art.51 c.p.
Il diritto di critica, consiste nel dissentire dalle opinioni espresse da altri, sottoponendo a critica le altrui tesi, affermazioni e condotte, sempre con fatti veri , continenti e pertinenti.
La Suprema Corte di Cassazione, nella sentenza , n. 15089 del 29/11/2019, dep. 2020, Cascio, Rv. 279084-01, ha affermato che l’esimente del diritto di critica postula una forma espositiva corretta, strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi nella gratuita ed immotivata aggressione dell’altrui reputazione, pur tuttavia consentendosi l’utilizzo di termini che, sebbene oggettivamente offensivi, siano insostituibili nella manifestazione del pensiero critico, in quanto privi di equivalenti adeguati.
Il diritto di critica, pertanto, deve essere espresso utilizzando modalità formali sempre confinate nei limiti del rispetto e della correttezza, senza che da ciò derivi, tuttavia, l’assoluta impossibilità di attingere a terminologie che, anche se ex se irriguardose, siano comunque uniche ed insostituibili per consentire l’esercizio della critica.
Nell’applicare il concetto al caso di specie, la Corte ha ritenuto configurabile l’indicata scriminante, per non essere stati travalicati i limiti di esercizio della critica, in un caso di utilizzo, in una pagina Facebook, dell’epiteto “idiota” nei confronti di un poliziotto, non identificato nominativamente, che aveva sparato dei colpi di arma da fuoco in pieno centro cittadino per arrestare la fuga degli autori di un reato. Tale offesa non è stata considerata un’immotivata e gratuita aggressione all’altrui sfera personale, ed anzi è parsa in termini di stretta riferibilità e attinenza all’accadimento fattuale oggetto di critica, intendendosi con essa unicamente stigmatizzare l’uso eccessivo della forza, sproporzionato rispetto al reato e alle condizioni di tempo e di luogo in cui il fatto si era svolto.
L’epiteto adoperato, non particolarmente aspro e pungente, è, in particolare, apparso non sproporzionato rispetto a quanto si era inteso rappresentare in relazione ad una situazione che, all’evidenza, si prestava ad essere oggetto di una qualche critica, presentando aspetti suscettibili di essere ritenuti gravi.
Il principio espresso si riferisce ad un orientamento ermeneutico reiteratamente affermato da parte della giurisprudenza della Corte.
Quindi, alle condizioni esposte, si può liberamente criticare l’opinione o l’operato altrui, senza temere di incorrere nel reato di diffamazione.
Avv. Fortunato Capellupo